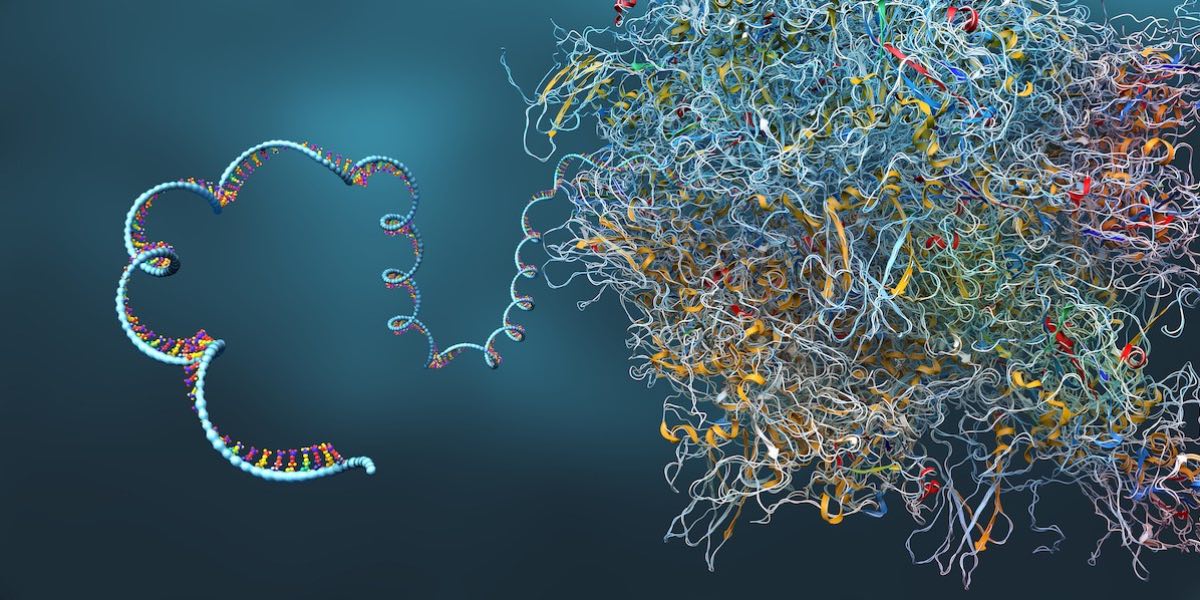Perché è importante capire gli effetti persistenti e a lungo termine della COVID-19
14 min lettura“Sintomi lievi”, “casi asintomatici”, “recupero in 14 giorni”, “casi positivi attivi”, “ospedalizzazioni”, “numero di tamponi”, “terapie intensive”, “decessi”, “guarigioni”. Sono queste le coordinate tra le quali ogni giorno ci muoviamo per poter interpretare l’entità dell’epidemia nei nostri paesi e i danni che COVID-19 può fare a ognuno di noi, nel caso in cui dovessimo malauguratamente contrarre il virus.
All’inizio di marzo, quando è stata dichiarata la pandemia, l’opinione diffusa era che si trattasse di un’infezione respiratoria con sintomi simili all’influenza. Si pensava che una minoranza degli infetti sviluppasse una polmonite atipica, avesse bisogno di un supporto respiratorio e finisse in terapia intensiva, mentre la maggioranza non andasse oltre una combinazione di tosse, febbre, fiato corto e perdita o alterazione del gusto e diminuzione dell’olfatto, che scompariva nel giro di un paio di settimane. Tra le persone più a rischio c’erano quelle anziane e/o con patologie pregresse.
L’idea diffusa era quella di trovarsi di fronte nella grande maggioranza dei contagi a persone asintomatiche o che manifestavano sintomi lievi (ai primi di marzo l’Organizzazione Mondiale della Sanità li aveva quantificati in circa l’80%) che in un arco relativamente circoscritto di tempo – 15 giorni, appunto – guarivano.
Poi, col passare dei mesi, man mano che abbiamo conosciuto meglio gli effetti del nuovo coronavirus, abbiamo capito che COVID-19, invece, è una malattia molto più complessa, con sintomi che possono andare dalle irritazioni della pelle all’interessamento dei sistemi cardiovascolare e cerebrale. E che, in diverse situazioni, proprio quei casi diagnosticati come lievi, spesso sfuggiti alle maglie della sorveglianza dei sistemi sanitari nazionali perché mai sottoposti a tampone molecolare, hanno avuto tempi di recupero molto più lenti.
Come Layth Hishmeh, 26enne di Camberley, nel Regno Unito, mai gravemente malato, che dopo essersi ripreso dalle prime due settimane di febbre e tosse, è collassato per strada mentre faceva la spesa. Convinto di essere guarito, da quattro mesi è vittima di una serie sconcertante di sintomi: spossatezza, mente annebbiata, tachicardia e diarrea. «Per un mese riuscivo a malapena a stare seduto. Poi il mese successivo ho sofferto di stitichezza. E anche da un punto di vista mentale, non va tanto bene. È traumatizzante», ha raccontato ad Anna Gross sul Financial Times.
Latyh Hishmeh è solo una delle delle tante persone che hanno avuto sintomi cosiddetti lievi o simil-influenzali e non sono mai finite in ospedale, hanno sviluppato più sintomi della malattia ma non hanno mai fatto il tampone o che, pur non avendo più una carica virale, continuano nel tempo a manifestare disturbi come pesantezza toracica, mancanza di respiro, dolori muscolari, palpitazioni e affaticamento. Sintomi persistenti, mai passati e classificati sotto la categoria di “forma lieve di COVID-19”, o insorti dopo che era stato testato che l’infezione non era più attiva.
Una recente analisi del Covid Symptom Study ha scoperto che nel Regno Unito fino a una persona su 10, che ha contratto COVID-19, è stata malata per più di tre settimane dopo la comparsa dei primi sintomi e che 3 pazienti su 4 hanno continuo a manifestare sintomi a mesi di distanza. Uno studio in Italia ha mostrato che l’87% dei pazienti ospedalizzati presentava ancora sintomi dopo due mesi, mentre una ricerca tedesca, che ha incluso anche molti pazienti in isolamento domiciliare, ha rilevato che il 78% aveva anomalie cardiache a distanza di due o tre mesi dai primi sintomi. Un’indagine dei Centers for Disease Control and Prevention, negli USA, ha scoperto che un terzo di 270 pazienti non ospedalizzati non è tornato al suo solito stato di salute dopo due settimane.
In questi casi si parla di COVID a lungo termine, longcovid o sindrome post-COVID. «Le persone sono bloccate a letto e non sono in grado di andare a lavorare o prendersi cura dei propri figli», spiega Timothy Nicholson, neuropsichiatra del King's College di Londra, che sta studiando il fenomeno dopo aver sofferto lui stesso dei sintomi della COVID a lungo termine.
A giugno, la giornalista britannica Vonny LeClerc ha dichiarato a The Atlantic di avere ancora disturbi a 80 giorni di distanza dalla comparsa dei primi sintomi. Ha iniziato con la tosse, sensazione di pressione sul petto, dolori articolari e formicolio sulla pelle. Dopo una settimana di riposo a letto, la situazione sembrava migliorare, ma all’improvviso dopo due settimane sintomi che sembravano superati sono tornati con maggiore intensità: la giornalista ha cominciato ad avere la febbre, ha perso il senso del gusto e dell’olfatto, faticava a respirare. Dopo due mesi, LeClerc ha detto di non riuscire a stare in piedi sotto la doccia senza sentirsi affaticata: «Non assomiglia a nulla che abbia mai avuto prima. Una volta ho provato ad andare al supermercato e sono rimasta a letto per giorni».
Paul Garner, professore di malattie infettive alla Liverpool School of Tropical Medicine, ha raccontato a luglio sul blog del British Medical Journal di non essere in grado di alzarsi dal letto per più di tre ore, di sentire costantemente un formicolio alle braccia e alle gambe, di avere un ronzio alle orecchie, di soffrire di annebbiamenti mentali a intermittenza e di avere palpitazioni e sbalzi d’umore improvvisi.
Cesar Abreu, ballerino del Metropolitan Opera di New York City, ha detto di essere stato del tutto debilitato dagli effetti prolungati della malattia. La stanchezza continua e forti emicranie paralizzanti hanno portato a diversi attacchi di panico: «Ciò che mi preoccupa di più è la permanenza del virus, l'impatto duraturo che potrebbe aver avuto sul mio corpo e il fatto che potrei rimanere così, senza trovare alcuna soluzione».
Molte di queste persone continuano a stare male senza però riuscire a capire perché la malattia non passa, quando staranno bene e se potranno tornare alle loro vite precedenti. Alcuni hanno iniziato a dubitare di essere realmente malati o a incolpare se stessi. Nella sua quarta settimana di febbre, Meg Hamilton, studentessa di infermieristica a Odenton, nel Maryland, negli USA, ha iniziato a preoccuparsi ossessivamente di aver usato il suo termometro in modo errato: «Mi sentivo anche come se non fossi abbastanza forte mentalmente, e dicendo a me stessa che non stavo bene, stavo prolungando il mio stato febbricitante».
Spesso si deve anche superare l’incredulità di amici e medici perché le proprie storie non si conformano al profilo tipico di malattia. «La gente sa come reagire se sente che stai migliorando. Ma quando i sintomi aumentano invece di diminuire, le persone non sanno cosa rispondere, smettono di chiedere o sono incredule. Alcuni mi hanno detto che tutto quello che mi accadeva era nella mia testa oppure era ansia», racconta Vonny LeClerc. Latyh Hishmeh, invece, ha detto di essersi sentito in questi mesi completamente privo di sostegno dai medici. Molti ritenevano che soffrisse di problemi di salute mentale e gli avevano prescritto farmaci anti-ansia.
«Sembra che nessuno capisca», racconta a The Atlantic Chloe Kaplan, americana, insegnante, giunta al 78esimo giorno di malattia. «Non credo che ci sia consapevolezza dei nostri casi, una via di mezzo tra chi si ammala gravemente e chi ha sintomi non duraturi. Noi non moriamo né però possiamo definirci un caso lieve».
Alcuni hanno allora cercato sostegno online per poter condividere storie, per potersi confrontare, per trovare soluzioni alla loro situazione. Un gruppo britannico, LongCovidSOS, ha lanciato una campagna per spingere il Governo a riconoscere questa condizione e finanziare ricerche al riguardo. Il sito longcovid.org raccoglie e pubblica storie di lungodegenti, mentre il Royal College of Occupational Therapists ha pubblicato tre guide per gestire l’affaticamento da post-COVID e conservare energia.
Il sistema sanitario nazionale del Regno Unito ha lanciato il sito “Your Covid Recovery” per raccogliere storie, offrire supporto e informazioni a persone che continuano a soffrire di disturbi pur non essendo più positive alla malattia e a luglio il Governo ha stanziato 9,3 milioni di euro per la ricerca sugli effetti a lungo termine di COVID-19, ma – spiega Trisha Greenhalgh, medico di base e docente all'Università di Oxford – «per essere idoneo, devi essere stato ricoverato in ospedale, e questo non ha senso». Negli USA, intanto, il sito dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC) continua a non far riferimento a questo fenomeno e il suo elenco di sintomi riflette a malapena l'intera gamma dei problemi neurologici, scrive Ed Yong su The Atlantic. A fine giugno, il vicedirettore dell'agenzia per le malattie infettive diceva ancora di non sapere se COVID-19 «potesse persistere per più di pochi mesi».
Molti si sono rivolti a gruppi di supporto sui social media e si sono sentiti sollevati dallo scoprire che non erano i soli a sperimentare sintomi così persistenti.
Nove giorni dopo essere stata dimessa dall’ospedale Fiona Lowenstein ha creato un gruppo su Slack (che conta ora più di 3.700 iscritti) per le persone alle prese con sintomi persistenti da più di un mese, al cui interno ci sono anche ricercatori e studiosi che stanno cercando quanto meno di mappare il fenomeno, sostituendosi agli istituti di ricerca ufficiali.
«Il gruppo è stata una salvezza per me», racconta Gina Assaf, consulente di design a Washington, negli USA, a giugno giunta al 77esimo giorno di malattia. Lei e altri membri con esperienza nella ricerca e nella progettazione di questionari e sondaggi hanno intervistato 640 persone. Dalla loro indagine, senza valore statistico, è emerso che il 56% non era stato mai ricoverato, il 38% era stato al pronto soccorso senza però essere ricoverato, quasi il 50% non era mai stato testato. Un quarto era risultato positivo al nuovo coronavirus e un altro quarto era risultato negativo, ma questo non significava che non avessero contratto la malattia.
Molti hanno riferito di avere la mente annebbiata e problemi di concentrazione. Alcuni hanno sperimentato stati allucinatori, momenti di delirio, perdita di memoria a breve termine e strane sensazioni di vibrazione quando toccavano le superfici. Altri hanno avuto probabilmente problemi con il loro sistema nervoso simpatico e hanno sperimentato sensazioni simili a un infarto. «È davvero un mistero. Ogni giorno ti svegli e potresti avere un sintomo diverso», ha commentato uno degli autori del questionario.
«È come se ogni giorno, estraiamo da un sacchetto una manciata di sintomi, li buttiamo su un tavolo e diciamo: “Ecco questo sei tu per oggi”», spiega David Putrino, neuroscienziato e specialista in riabilitazione presso il Mount Sinai Hospital, uno dei pochi specialisti a seguire alcuni pazienti che stanno manifestando sintomi persistenti di COVID-19. «È spaventoso perché abbiamo tutti questi giovani che escono pensando di essere invincibili e, invece, potrebbero sviluppare questa forma di patologia che potrebbe metterli facilmente fuori combattimento per mesi. E per alcuni, i mesi di malattia potrebbero trasformarsi in anni di invalidità».
Quali sono le cause di questi disturbi persistenti?
Non è chiaro il motivo per cui questo accade. Secondo John Geddes, professore di Epidemiologia all'Università di Oxford, i sintomi persistenti della malattia sono probabilmente causati dal nuovo coronavirus che penetra nelle cellule nervose del cervello.
Akiko Iwasaki, immunologa a Yale, offre tre ipotesi. Le persone che soffrono di longcovid potrebbero continuare a ospitare il virus in qualche organo serbatoio e, pertanto, non viene rilevato dai tamponi nasali. Oppure frammenti persistenti di geni virali, sebbene non contagiosi, innescano una reazione immunitaria violenta ed eccessiva, come se «si stesse reagendo a un fantasma di un virus», dice Iwasaki. O, ancora, più probabilmente, il virus è scomparso ma il sistema immunitario, sollecitato, resta in uno stato di iperattività persistente.
In quest’ultimo caso, spiega Ed Bullmore, neurobiologo dell’università di Cambridge e autore del libro The Inflamed Mind, i disturbi potrebbero essere «l’effetto della nostra risposta immunitaria all’infezione. Quando le cellule immunitarie incontrano un intruso, rilasciano molecole-segnale chiamate citochine per rafforzare la risposta immunitaria. Alcune di queste molecole finiscono nel cervello e innescano un’ulteriore secrezione di citochine e una conseguente infiammazione».
Secondo il dottor Putrino, molti longcovid hanno sintomi che ricordano i disturbi del sistema nervoso autonomo, che controlla le funzioni corporee come la respirazione, la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna e la digestione. Il danno a questo sistema, sia esso inflitto dal virus stesso o da una risposta immunitaria eccessivamente intensa, potrebbe spiegare perché molte di queste persone lottano per respirare quando i loro livelli di ossigeno sono normali, o hanno battiti cardiaci instabili quando non si sentono ansiosi. Le cose che una volta erano automatiche ora sono irregolari.
Putrino è arrivato a riconoscere il longcovid da solo. A marzo, ha notato che alcuni pazienti che erano stati mandati al suo ospedale erano in cattive condizioni ma non abbastanza malati da essere ricoverati. Allora ha creato una app per tenere traccia di queste persone da remoto. Alla fine di maggio, il suo team si è reso conto che circa il 10% dei pazienti non stava migliorando e oltre il 90% soffriva di “malessere post-sforzo”, per cui anche piccoli momenti di sforzo fisico o mentale possono provocare un grave incidente fisiologico. «Stiamo parlando di salire una rampa di scale ed essere fuori casa per due giorni», spiega il medico. Questo potrebbe far pensare a una sindrome da stanchezza cronica.
Tuttavia, è difficile distinguere tra tutte queste ipotesi, commenta Ed Yong su The Atlantic, perché SARS-CoV-2 è nuovo e le conseguenze della sua infezione virale sono poco conosciute. Ma, dice a New Scientist Julian Hiscox, virologo dell’università di Liverpool, studioso dei coronavirus dall’inizio degli anni Novanta, in nostro aiuto può venire l’esperienza maturata con la SARS e la MERS. Anche in quel caso, «alcune persone si riprendevano, mentre altre continuavano a star male».
Circa il 28% delle persone che hanno contratto la SARS ha continuato a presentare un’insufficienza polmonare 18 mesi dopo la scomparsa dei sintomi della malattia, con un peggioramento della qualità della vita e della capacità di svolgere esercizio fisico, si legge nell'articolo su New Scientist. E "una meta-analisi recente suggerisce che nei mesi successivi alla guarigione dalla SARS il 10-20% dei pazienti soffriva di depressione, ansia, insonnia e spossatezza".
Anche nel caso dell'epidemia di Ebola in Africa occidentale nel 2014, ci sono stati casi di "sindrome post-Ebola", con persone affette da stanchezza cronica fino a due anni dopo l’infezione.
Nel caso di COVID si può parlare di encefalomielite mialgica o sindrome da stanchezza cronica?
Tra le ipotesi sollevate, c’è quella suggerita dal dottor Putrino che i casi di longcovid possano rientrare nella cosiddetta sindrome da stanchezza cronica (CFS) o encefalomielite mialgica (ME), definita nel 2015 dall’Institute of Medicine (IOM) come una “malattia sistemica, complessa, cronica e grave”, caratterizzata da una “profonda stanchezza, disfunzioni cognitive, alterazioni del sonno, manifestazioni autonomiche, dolore e altri sintomi, che sono peggiorati da uno sforzo di qualsiasi tipo”.
Secondo la definizione dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC), la ME/CFS è una “malattia seria, di lungo periodo che colpisce molti apparati dell'organismo, riducendo o impedendo le normali attività dei pazienti, talvolta costringendoli a letto. Questa malattia comporta una “fatica schiacciante” e tanti altri sintomi che non migliorano col riposo e che possono peggiorare dopo l'attività fisica o uno sforzo mentale”. In Europa, stando a uno studio recente, ne sono affetti 2 milioni di persone, nel 75% dei casi donne.
Già nel caso di altri virus, come il virus Ross River, in Australia, la mononucleosi infettiva o la febbre Q, ad alcuni pazienti che presentavano sintomi persistenti è stata diagnosticata la sindrome da stanchezza cronica. In uno studio su 233 residenti di Hong Kong che sono sopravvissuti all'epidemia di SARS del 2003, circa il 40% ha avuto problemi di stanchezza cronica per circa tre anni.
La ME/CFS viene tipicamente diagnosticata quando i sintomi persistono per sei mesi e, nel caso della COVID-19, non è passato ancora così tanto tempo da quando è scoppiata la pandemia da poter parlare con certezza di questa sindrome. Inoltre, alcuni pazienti si riprendono prima della soglia dei sei mesi, altri non hanno malessere post-sforzo, altri ancora hanno danni ai polmoni e problemi respiratori che non sono sintomi tradizionali della ME/CFS. Tuttavia, spiega a The Atlantic Jennifer Brea, direttrice esecutiva del gruppo di difesa #MEAction, «molti dei sintomi dei longcovid sono simili a quelli vissuti dai pazienti della nostra comunità» e l’esperienza di chi soffre di sindrome da stanchezza cronica può essere d’aiuto a chi manifesta sintomi persistenti di COVID-19, considerato che anche loro hanno dovuto superare perplessità di medici e funzionari sanitari e lottare affinché la loro patologia venisse riconosciuta e si facessero delle ricerche per individuare delle cure.
Che sia sindrome da stanchezza o meno, la cosa più importante è riconoscere il malessere di questi pazienti e iniziare ad aiutarli, raccogliendo dati e cercando di capire cosa sta succedendo loro per poter arrivare a una diagnosi esatta e capire se ci troveremo di fronte a persone con disabilità cronica, dice ancora Putrino. Capirlo è importante, considerate le ricadute da un punto di vista assistenziale, professionale e sanitario.
Essere negativi al tampone non significa piena guarigione
Per poter dare riconoscibilità alla condizione di chi soffre di sintomi persistenti e a lungo termine della COVID-19 è necessario ridefinire il concetto stesso di guarigione e associarlo al pieno recupero delle proprie capacità fisiche. Lievi o gravi che siano, si deve parlare di guarigione solo se i sintomi cessano di insorgere, spiega in un articolo pubblicato su Nature, Nisreen Alwan, professoressa associata di Salute Pubblica all’Università di Southampton nel Regno Unito.
L’errore è a monte, prosegue la professoressa: finora, nel tentativo di cogliere gli impatti di COVID-19, ci si sta focalizzando solo sul numero di morti, contagi, terapie intensive e casi gravi che necessitano dell’ospedalizzazione, e si associa la guarigione al momento in cui non si risulta più positivi al tampone e si viene dimessi dall’ospedale. Ma, sottolinea Alwan, così facendo si crea un divario nel quantificare e caratterizzare la malattia in coloro che non sono ricoverati.
tested false negative (PCR sensitivity 70-80%)
tested late in the course of illness to have significant viral load to detect
asymptomatic
Out of this wider pool of cases, we need to define recovery so we can measure the proportion who have prolonged symptoms #LongCovid 2/3— Dr Nisreen Alwan (@Dr2NisreenAlwan) August 12, 2020
Questo accade perché tutte queste sintomatologie, che passano per “COVID lieve”, restano nella sfera dell’aneddotica e delle storie personali e faticano a essere analizzate in studi sistematici e a essere classificate come casi clinici. Ad oggi, non abbiamo un’idea precisa di chi è a maggior rischio di morire per il nuovo coronavirus, non siamo in grado di sapere chi ha più probabilità di soffrire di problemi di salute prolungati nel tempo a seguito di una infezione sintomatica o addirittura asintomatica, non sappiamo quali segni sul corpo lascia COVID-19 anche dopo che l’infezione non è più attiva e per quanto tempo, e se la malattia si cronicizza.
Abbiamo bisogno di ampliare la prospettiva secondo un approccio che tenga conto della qualità della vita del paziente, prosegue la professoressa di Salute Pubblica, non concentrandoci solo sui casi gravi che necessitano di ospedalizzazione ma analizzando sistematicamente anche i cosiddetti casi di “COVID lieve”. Il grado di gravità della malattia deve essere valutato in base alla sua durata e non solo dalla necessità di ricovero in ospedale, scrive sempre Alwan in un altro post pubblicato sul blog del British Medical Journal (ndr, qui tradotto in italiano).
I passi da fare sono due: 1) Individuare tutte quelle sintomatologie alle quali si fa riferimento quando si parla di forma lieve di malattia; 2) Definire un nuovo concetto di guarigione che includa “la durata, la gravità e la fluttuazione dei sintomi, nonché la funzionalità e la qualità della vita”.
"Non possiamo combattere ciò che non analizziamo o conosciamo", dice Alwan. “Quello che ora è sempre più chiaro è che la mortalità non è l’unico esito negativo di questa infezione e i sistemi di sorveglianza devono tenere il passo e prenderne atto. Dobbiamo tener conto anche di come cambiano le vite di chi contrae il virus”. Solo così potremo conoscere davvero tutta la posta in gioco della pandemia.
Valutare come un paziente recupera dalla malattia non è semplice, considerato che i sistemi sanitari sono già sotto stress per curare chi lotta per la vita, spiega la professoressa. Si potrebbero creare dei registri delle malattie, simili a quelli dei malati di cancro, per monitorare le persone nel tempo e registrare le loro condizioni, attraverso controlli mensili e successivamente annuali. Inoltre, vanno fatti studi sulle caratteristiche di coloro che soffrono di sintomi persistenti per imparare a identificare e proteggere chi è più vulnerabile.
We need to capture this by having universal clinical case definitions for severity and recovery to assess the true impact of the pandemic and how to manage it & prevent it. Otherwise what we have now is an inaccurate picture.
More in my article here:https://t.co/EXZKZpYlCn 3/3— Dr Nisreen Alwan (@Dr2NisreenAlwan) August 12, 2020
Partendo dai vissuti di malattia, conclude Alwan, si deve arrivare a una descrizione universale e precisa dei casi clinici per severità e guarigione in modo tale da valutare e prevenire gli impatti reali della pandemia. Abbiamo bisogno di definire quando si può parlare di effettiva guarigione dalla malattia per capire se e in che proporzioni COVID-19 lascia dei segni e rischia di cronicizzarsi. Altrimenti, avremo sempre una percezione erronea della malattia e dei suoi effetti nel tempo.
Immagine in anteprima via pixabay.com